Università

Università di Pavia: Guida all'Educazione nella Città Universitaria
Chi indugio dinanzi all’edificio dell Università e legga sopra le sue porte le iscrizioni che ricordano la munificenza di Maria Teresa e di Giuseppe II rivive in quella gloriosa età che inizia il nostro secondo risorgimento; quando l’ateneo pavese meritava la superba lode del Mascheroni:
Guidate il sai, dalla cesarea mano,
l’attiche discipline, e di molt’ oro
sparse, ed altere di famosi nomi
parlano un suon che attenta Europa ascolta
Cantando nel 1777 la laurea di Maria Pellegrina Amoretti, Giuseppe Parini aveva scritto:
Ed oro la risorta insubre Atene
Con strana meraviglia
Le lunghe tracce a coronar ti viene,
o di Pallade figlia,
io, rapito al tuo merto
fra i portici solenni e l’alte menti mi inoltro….
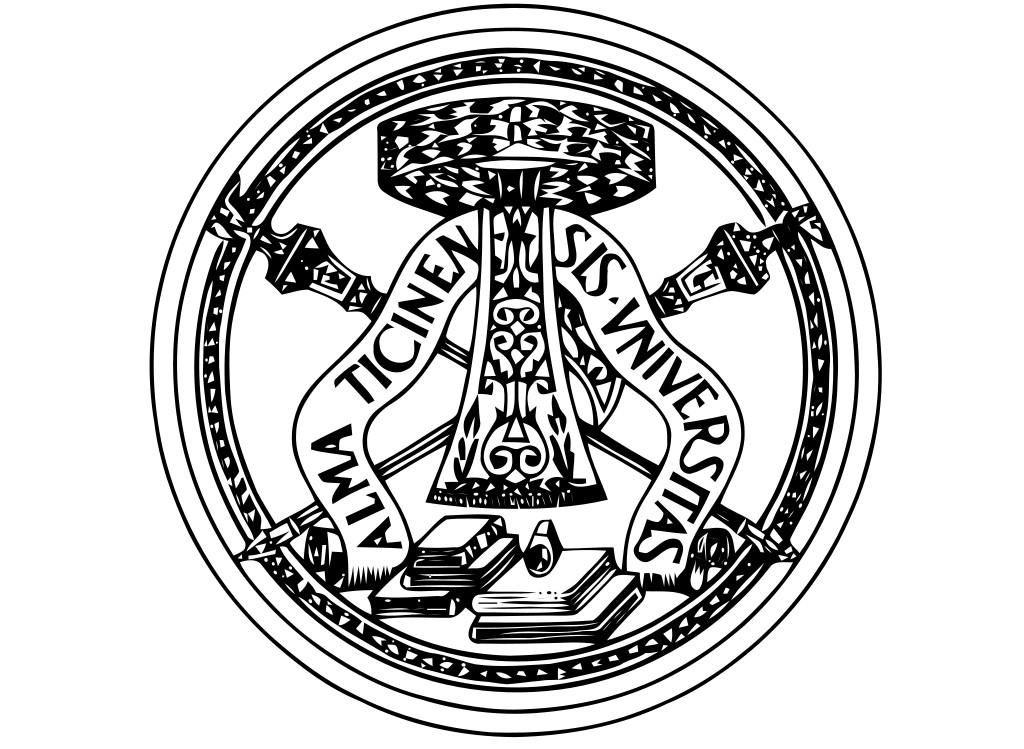
Logo dell'Università di Pavia
I portici solenni dell’ode pariniana sono i portici rinnovati sul disegno di Giuseppe Piermarini.
Il primo edificio dell’ Università di Pavia fu lo sforzesco , eretto da Ludovico il Moro tra S. Maria Nova e S. Matteo e inaugurato nel 1485, per raccogliere in un solo luogo i vari insegnamenti che in antico si impartivano in diversi punti della città. Recentemente, facendosi alcuni lavori in uno dei cortili dell’ Università, si sono scoperte alcune finestre ad arco acuto, che sono ricordo del primitivo edificio universitario.
Ai tempi di Maria Teresa, questa fabbrica consisteva in poche aule, nelle quali si entrava attraverso due vecchi cortili a levante, con duplice portico in giro di colonne doriche di granito, accoppiate con archi di forma poligonale e sbarre di legno negl’ intercolumni del loggiato superiore, con una scala incomoda e di cattiva forma; e all’esterno aveva una sola facciata a ponente, terminata da una grondaia di legno. Maria Teresa, sui disegni del Piermarini, fece arrotondare gli archi, sostituire ai parapetti di legno delle balaustre di pietra, costruire una scala assai più comoda e grandiosa, e decorare la facciata con fasce e cornice architravata con mutali di granito, sormontata da un attico, e le due porte d’ordine dorico ornare con pilastri pure di granito. Come si rileva da una medaglia del 1772, che si conserva nel medagliere del museo civico, i frontoni delle due porte avrebbero dovuto essere sormontati da gruppi statuari ; guita. I lavori (compreso il nuovo ampio salone della biblioteca) furono compiuti nel 1779.
Giuseppe II ampliò in seguito la fabbrica, sopprimendo il monastero del Leano; e sui disegni di Leopoldo Pollach, scolaro del Piermarini, fece erigere una parte del terzo cortile, detto allora Portico Teologico (1786): nel cui piano superiore fu costruito il teatro fisico, a imitazione dell’ olimpico del Palladio, con marmoree colonne e con le statue di Galileo e del Cavalieri, cui si aggiunse più tardi il busto del Volta. Dalla parte di tramontana, di là dal fabbricato vecchio dell’ Università, acquistate alcune case di privati, si innalzò il teatro anatomico con gli attigui gabinetti al pianterreno, e superiormente le gallerie del museo di storia naturale. Il teatro anatomico, eretto dal Pollach, affrescato da scolari dell’Appiani, fu inaugurato dallo Scarpa nel 1785. I tumulti del 1796 fecero sospendere i lavori, che furono ripresi solo nel 1909, quando fu costruito, su disegno del Pollach, il laboratorio di chimica. Nel 1821 si aprirono le due altre grandi porte verso strada Nuova, come il popolo chiama ancora la strada aperta sotto Galeazzo II Visconti,l’ odierno corso Vittorio Emanuele. Nel 1823 si compì il magnifico scalone adorno di stucchi. Nel 1850 fu inaugurata l’aula magna , costruita a modi di tempio dorico da Giuseppe Marchesi, a cui si debbono ampliamenti dell’Università nella prima metà del secolo XIX.
Nell'aula Magna è un gran ritratto equestre di Vittorio Emanuele, di G. Trecourt.
Sopra la porta principale s’innalza la torre dell’orologio, costruita dal Marchesi. L’ interno si divide in cinque cortili circondati da portici maestosi sostenuti da più di trecento colonne di granito.
Il primo cortile, che si trova subito entrando per la porta principale, ha , fra le altre, le lapidi commemorative del Monti, del Foscolo, di Lorenzo Valla, di Valentino, di Tullio Brugnatelli, lavoro di A. Marabelli, un ricordo, con busto, di Carlo Cantoni, un busto del Romagnosi, una statua di Antonio Bordoni, opera di Antonio Tantardini, e le statue di B Panizza e L porta del Martegani, un busto di Adolfo Borgognoni, di E. Rinaldi.
Il secondo cortile, a mezzodì ( a destra, entrando dalla porta principale), serve d’ingresso agli uffici: vi si vede, fra gli altri, un ricordo di bronzo e marmo di E. Beltrami, opera di G. Kienerk. Da questo si accede al terzo cortile, ove nel 1884 fu inaugurato un busto di Cristoforo Colombo, che studiò, secondo alcuni storici, a Pavia. Su due pareti di questo cortile sono infissi alcuni cimeli archeologici, che fanno parte del gabinetto archeologico dell’ Università.
Il secondo cortile a settentrione (a sinistra entrando per la porta principale) ha nel suo mezzo la statua di Alessandro Volta di A. Tantardini (1878), Sulla parete occidentale si vede murata la lapide più antica (1390) che riguardi l’ Università di Pavia, già esistente nella cappella di santa Caterina della chiesa di S. Tomaso. In questo cortile sono stati allogati, trasportativi dalle chiese di Pavia, i più antichi marmi che ricordino i professori dell’ Università. Ricorderò i più importanti. Ve n’ha del secolo XIV, come il monumento di Baldo da Perugia, morto a Pavia l’anno 1400; del secolo XV, come quelli di Giasone del Maino, legum monarcha, che insegnò qui diritto dal 1467 al 1483 e dal 1490 al 1512, e di Cristoforo Bottigella; e del secolo XVI, come il busto di Jacopo Menochio, professore di diritto dal 1555 al 1589, e il monumento onorario di Andrea Alciato, storico legista filosofo, veramente degno di quel dottissimo elegantissimo ingegno. Si vede anche in questo cortile il busto del Marchesi, architetto dell'Università, dopo il Piermarini e il Pollach, e un ricordo di Ercole Vidari.
Il terzo cortile ci ricorda, tra gli altri, con due lapidi infisse nella parete orientale, i nomi di L. Mascheroni e L. Spallanzani e , con un piccolo monumento, opera di G. Franchi, il nome del Borsieri. Nel mezzo del cortile, è stato eretto un monumento di marmo e bronzo agli studenti caduti nella guerra. Opera di A. Mirabelli.
Dai cortili salendo alla biblioteca, si vedono il monumento Tamburini, con busto scolpito dal Comolli; il monumento Mangili, disegnato dal Marchesi, con busto scolpito dal San Giorgio; il monumento Rezia , disegnato dal Marchesi, con busto del Comolli.
Le Conche sul Naviglio
Tra le grandi opere dovute al genio imperioso di Napoleone, non si può dimenticare il naviglio, vagheggiato fin dal secolo XV, che mette in comunicazione Milano con Pavia.
Napoleone decretava da Mantova il 20 giugno 1805: “Il canale da Milano a Pavia sarò reso navigabile”. Nel 1807 si pose mano ai lavori secondo il disegno degli ingegneri Giussani e Giudici e del Prof. Brunacci, che lo compilarono giusta le idee di Paolo Frisi, che già nel 1772, per ordine di Maria Teresa, aveva da par suo studiato il problema. I lavori, più volte interrotti e ripresi a causa degli sconvolgimenti politici, ebbero termine nel 1819.
Vero capolavoro d’architettura idraulica, gareggiante anche per solidità ed eleganza di costruzione con le grandi opere romane , sono le dodici conche le quali, rendendo insensibile lo dislivello del terreno e regolando la caduta e la corrente delle acque, agevolano la navigazione con guidare grosse barche dall’alto al basso e dal basso all’alto in brevissimo tempo.
Fonte: Pavia e i suoi monumenti
Gallery




